Dalla partecipazione alla democrazia partecipativa (seconda parte)
(Sergio De La Pierre, del “Laboratorio di democrazia partecipata. Per un nuovo spazio pubblico”)28/11/2012
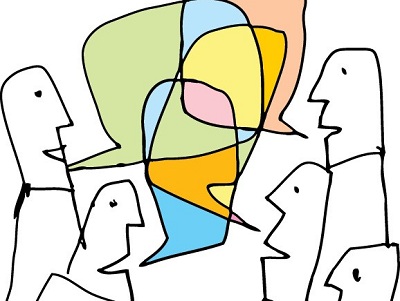
Quel che ci interessa sottolineare è il fatto che la “partecipazione”, nata spesso per affrontare problemi sociali che le istituzioni tradizionali non erano (o non sono mai state) in grado di risolvere, si configura all’inizio quasi sempre come “partecipazione dal basso” (bottom up), ma in alcune amministrazioni locali si fa sempre più strada la necessità di una svolta delle loro tecniche di governance in senso “partecipativo”. Questa “partecipazione dall’alto” (top down) tuttavia comporta dei rischi, nel senso di sovrapporre alle esigenze dei cittadini “partecipanti” le logiche burocratiche e le tempistiche delle istituzioni, e soprattutto di trasformare i percorsi partecipativi in tecniche di costruzione del consenso verso decisioni sostanzialmente già prese. D’altro canto una partecipazione esclusivamente “dal basso” corre rischi opposti: contrariamente ai rappresentanti istituzionali, i “cittadini attivi” che intendono “partecipare” sono sempre un’esigua minoranza della popolazione (il 2-4% nei casi più strutturati) e quindi non possono avere pretese “rappresentative” dell’intera cittadinanza. Se poi continuano a portare avanti le loro elaborazioni e i loro progetti in modo autonomo, “solo dal basso”, senza alcuna sponda istituzionale, rischiano di elaborare magari soluzioni meravigliose ai problemi socio-territoriali senza alcuna possibilità di implementarli con la necessaria titolarità giuridica.
Ecco allora nascere, e sempre più diffondersi nella coscienza dei diversi soggetti che operano nella “partecipazione”, la consapevolezza della necessità di costruire in ogni percorso partecipativo, perché esso abbia successo, un’interlocuzione costante tra istanza istituzionale e “galassia” della società civile che lavora a un determinato progetto. Questa “relazione feconda”, che ha prodotto anche in Italia esperienze significative, è quella che si chiama “democrazia partecipativa”: quindi non solo decisioni prese in nome della democrazia indiretta delle elezioni canoniche, che spesso generano negli eletti la presunzione di “poter fare quello che vogliono”, ma nemmeno “partecipazione” priva di ogni effettivo potere decisionale, che al massimo si riduce a “consultazione” dei cittadini da parte di amministrazioni più sensibili.
La democrazia partecipativa dunque significa un processo virtuoso (non privo naturalmente di problemi, conflitti, difficoltà che si tratta di volta in volta di affrontare in modo “autoriflessivo”) che mette in relazione costruttiva e creativa il “protagonismo” dei cittadini con i processi decisionali delle istituzioni, specie a livello locale.
Questa definizione è alla base, mi pare, di una declinazione più matura del concetto di partecipazione. Questa parola contiene il termine “parte”, dunque implica la parzialità di posizione e di potere di qualcuno nei confronti di un’altra entità che si presume essere “il tutto”. Questa è l’idea sottesa alla partecipazione declinata solo “dal basso” o solo “dall’alto”. La democrazia partecipativa invece implica un ruolo essenziale, ma anche una rimessa in discussione dei significati “autoconsapevoli” dei due soggetti in campo: le istituzioni e la società civile. Le istituzioni perdono le loro pretese “totalizzanti” e le aggregazioni sociali perdono il loro perenne senso di impotenza. Partecipazione finisce così col significare parte-in-azione (o partner-in azione), consapevolezza della parzialità di tutti i soggetti in campo, la quale soltanto può fondare davvero un’idea di partecipazione come possibilità di “fecondazione reciproca” tra soggetti sociali tutti consapevoli dei propri limiti e quindi dell’indispensabilità dell’altro, del rapporto con l’altro.
Per saperne di più
G. Ferraro, Rieducazione alla speranza. Patrick Geddes planner in India, 1914-1924, Jaca Book 1998;
P. Savoldi, Giochi di partecipazione. Forme territoriali di azione collettiva, Franco Angeli 2005 (vi si descrivono, tra altre, le esperienze di Adriano Olivetti, Giancarlo De Carlo e Danilo Dolci);
A. Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri 2010.




