Chiuso il Festival del cinema Africano, d'Asia e America latina
A Porta Venezia una grande finestra sul mondo. Occasione unica per conoscere e riflettere. Un appuntamento da non perdere.
(Adalberto Belfiore)13/05/2013
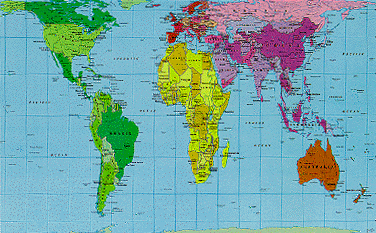
(Adalberto Belfiore)13/05/2013
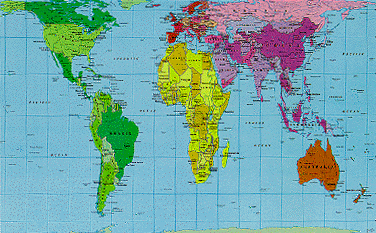
Un grande maestro chocolatier parigino oltre a produrre raffinatissime praline per i buongustai di tutto il mondo si diletta a costruire grandi sculture di cioccolato: un gorilla della foresta, una bellissima figura di donna, sculture astratte. Ma siccome il cioccolato ha il difetto di sciogliersi al caldo le sculture vengono replicate in bronzo, pensando all’eternità. A Hershey in Pennsylvania attorno all’industria del cioccolato è prosperata una città, con tanto di enorme parco divertimenti da far invidia a Disneyland. La città più dolce del mondo, dicono le scritte stradali di benvenuto. “Anche quando la natura ci regala freddo e pioggia noi sentiamo l’inebriante odore proveniente dalle nostre industrie cioccolatiere e siamo felici” si vanta tutta fremente d’amore la direttrice del parco. Due giovani dall’aria ispirata, sexy e felice, lui barbuto e lei provvista di lunghe e ben fatte cosce new age generosamente esibite, si divertono a prendere il sole sdraiati sulla distesa di un lago ghiacciato in non mi ricordo quale contrada del Canada, deliziando con piroette gioiose un bel bambino, naturalmente biondissimo. Il segreto di tanta allegra vitalità? Ma il cioccolato naturalmente. Però preparato dalla giovane coppia di prosperi strafigoni secondo l’antica ricetta azteca, ossia puro al 100%. Manna, nettare e ambrosia in un solo prodotto. Grande successo commerciale, manco a dirlo, con contorno di ritiri spirituali sotto una grande statua del Budda per deliziare truppe di correligionari in cerca di illuminazioni non certo a buon mercato. Un alimento ricco e prezioso, il cioccolato azteca,  degno di essere offerto addirittura alla NASA per i suoi astronauti. Ma a due giovani africani, dopo una giornata infinita passata a raccogliere i preziosi grani nel cuore della Costa d’Avorio, viene chiesto se sanno a cosa serve ciò che loro passano la vita a raccogliere per una paga da fame. No, non lo sanno. Sanno solo che devono riempire quelle ceste e che qualcuno verrà a portarsele via. Ma quei grani scuri di cui il loro paese è il principale produttore mondiale a cosa servono non sanno proprio. Allora una mano entra nel campo visivo della cinepresa e offre loro un pezzetto di quella morbida sostanza, marrone come la loro pelle, prendendola da una bella confezione, sfavillanti colori e carta argentata, di quelle che tutti noi conosciamo. I due lavoratori, curiosi ma circospetti, naturalmente l’assaggiano. E muovono le bocche come fanno i cavalli masticando un buon fieno odoroso. Ma, a differenza di quelli equini, i loro sguardi si illuminano. “È buonissimo” sospirano, tra delizia e rassegnazione, i due giovani raccoglitori. E qui il documentario, documentario d’autore, si chiude lasciando allo spettatore la sensazione di aver capito, riguardo al mondo in cui vive, qualcosa di più profondo del solito.
degno di essere offerto addirittura alla NASA per i suoi astronauti. Ma a due giovani africani, dopo una giornata infinita passata a raccogliere i preziosi grani nel cuore della Costa d’Avorio, viene chiesto se sanno a cosa serve ciò che loro passano la vita a raccogliere per una paga da fame. No, non lo sanno. Sanno solo che devono riempire quelle ceste e che qualcuno verrà a portarsele via. Ma quei grani scuri di cui il loro paese è il principale produttore mondiale a cosa servono non sanno proprio. Allora una mano entra nel campo visivo della cinepresa e offre loro un pezzetto di quella morbida sostanza, marrone come la loro pelle, prendendola da una bella confezione, sfavillanti colori e carta argentata, di quelle che tutti noi conosciamo. I due lavoratori, curiosi ma circospetti, naturalmente l’assaggiano. E muovono le bocche come fanno i cavalli masticando un buon fieno odoroso. Ma, a differenza di quelli equini, i loro sguardi si illuminano. “È buonissimo” sospirano, tra delizia e rassegnazione, i due giovani raccoglitori. E qui il documentario, documentario d’autore, si chiude lasciando allo spettatore la sensazione di aver capito, riguardo al mondo in cui vive, qualcosa di più profondo del solito.
Questo è stato il 23° Festival del cinema africano, d’Asia e America latina, il cui centro è stata la Casa del Pane di Porta Venezia, conclusosi venerdì scorso: una inusuale grande finestra sul mondo in grado di cambiare le nostre prospettive, di liberarci da una visione ottusamente eurocentrica come ha saputo fare, su un altro piano, la cartografia di Arno Peters in cui a ogni paese è restituita la sua vera proporzione. Uno sguardo profondo su abissi e speranze, lontananze incommensurabili e vicinanze inquietanti. Come quella degli indios Tarahumara del Messico, abituati a parlare con gli spiriti degli antenati, e forse anche con Dio, lungo le immensità senza fine delle loro montagne e ora costretti a osservare pieni di muta indignazione un intraprendente imprenditore meticcio comprare la loro terra, senza che peraltro loro gliel’abbiano mai venduta, e farci sopra una grande funivia destinata a portare frotte di turisti nel cuore stesso della loro memoria.
“Noi non vogliamo emarginare i nativi, semmai vogliamo integrarli nello sviluppo e nel benessere.” proclama l’imprenditore a beneficio dei notiziari nazionali, con un disprezzo della verità a cui siamo forse più assuefatti noi dei poveri indios messicani. Ma intanto per far spazio ai nuovi resort e alle strutture commerciali saranno demolite le case, la scuola, la chiesa e perfino il cimitero, lasciando i vecchi a pensare se i loro morti resteranno ancora dove hanno vissuto, come fanno dai tempi della creazione. E anche a dove dovranno mai andare loro stessi. Da vivi e da morti.
Chissà chi sapeva che nella Siria devastata dalla guerra civile e dalla repressione genocida del regime di Assad è fiorita una creatività artistica senza precedenti. O che la Cina, lo stesso paese in cui è tradizione agghindare i cadaveri di certe donne per offrirle in spose nell'aldilà a ricchi signori morti per loro sfortuna in stato di celibato, molto più materialisticamente sta prendendosi a buon mercato l’oro e la terra della Tanzania. O cosa stia succedendo nella Tunisia che ha dato inizio alla primavera araba e come stiano cambiando le relazioni tra gli abitanti delle due sponde del Mediterraneo. E quali sono le cause della penetrazione del terrorismo in Mali? Perché una famiglia mista è accolta meglio in Senegal che qui da noi? Non è incoraggiante che un ragazzino dotato solo di un innato senso dell’umorismo riesca a mobilitare la sua comunità, nell’isola di Giava, Indonesia, affinché l’acqua rimanga bene comune e siano sconfitti i piani per privatizzarla? Possibile che una signora del Cairo andando al mercato ci spieghi i meccanismi del potere e della creazione del consenso meglio che qualunque nostro paludato commentatore? Siamo consapevoli del fallimento epocale del sistema di aiuti internazionali, la cosiddetta costosissima ‘poltiglia umanitaria’, il cui punto più basso è stato raggiunto ad Haiti nella gestione dell’emergenza dopo il terremoto del 2010 sotto la guida nientemeno di Bill Clinton? Qualcuno sta riflettendo sull’impropria connessione tra aiuti, cooperazione e logica del profitto e sulla debolezza manifestata dall’intero sistema delle cosiddette democrazie occidentali in quanto a capacità decisionali e visione del futuro? E così via. Per una settimana ognuno ha potuto percorrere in lungo e in largo il mondo seguendo i suoi interessi e le sue passioni. Dall’India alla Cina profonde, dall’Africa devastata ma piena di vita all’America Latina che ha archiviato per sempre il tempo delle dittature e cerca di riconoscere il suo futuro.

Ma abbiamo potuto guardare da questa finestra grazie all’aiuto di occhi partecipi, sentimenti profondi, sensibilità politiche e poetiche, artistiche e sociali come il cinema hollywoodiano e i suoi miti di cartapesta, certamente superiori per mezzi e fulgore di effetti speciali, quotidianamente e scientificamente ci abituano a non fare. Non mi è sembrato importante riportare chi ha vinto le varie sezioni, chi ha avuto più successo o applausi. L’importante, anche in vista del mitico Expo 2015 con cui il Festival ha costruito precise connessioni, è osservare che Milano, o almeno la sua parte più sensibile e aperta, affollando tutte le sale e le manifestazioni collaterali, ha dato l’idea di cogliere questa grande occasione di conoscenza e riflessione senza cui non è possibile neppure immaginare il nostro futuro. Con l’auspicio e la speranza che chi l’ha fatto non perda l’occasione il prossimo anno.
 degno di essere offerto addirittura alla NASA per i suoi astronauti. Ma a due giovani africani, dopo una giornata infinita passata a raccogliere i preziosi grani nel cuore della Costa d’Avorio, viene chiesto se sanno a cosa serve ciò che loro passano la vita a raccogliere per una paga da fame. No, non lo sanno. Sanno solo che devono riempire quelle ceste e che qualcuno verrà a portarsele via. Ma quei grani scuri di cui il loro paese è il principale produttore mondiale a cosa servono non sanno proprio. Allora una mano entra nel campo visivo della cinepresa e offre loro un pezzetto di quella morbida sostanza, marrone come la loro pelle, prendendola da una bella confezione, sfavillanti colori e carta argentata, di quelle che tutti noi conosciamo. I due lavoratori, curiosi ma circospetti, naturalmente l’assaggiano. E muovono le bocche come fanno i cavalli masticando un buon fieno odoroso. Ma, a differenza di quelli equini, i loro sguardi si illuminano. “È buonissimo” sospirano, tra delizia e rassegnazione, i due giovani raccoglitori. E qui il documentario, documentario d’autore, si chiude lasciando allo spettatore la sensazione di aver capito, riguardo al mondo in cui vive, qualcosa di più profondo del solito.
degno di essere offerto addirittura alla NASA per i suoi astronauti. Ma a due giovani africani, dopo una giornata infinita passata a raccogliere i preziosi grani nel cuore della Costa d’Avorio, viene chiesto se sanno a cosa serve ciò che loro passano la vita a raccogliere per una paga da fame. No, non lo sanno. Sanno solo che devono riempire quelle ceste e che qualcuno verrà a portarsele via. Ma quei grani scuri di cui il loro paese è il principale produttore mondiale a cosa servono non sanno proprio. Allora una mano entra nel campo visivo della cinepresa e offre loro un pezzetto di quella morbida sostanza, marrone come la loro pelle, prendendola da una bella confezione, sfavillanti colori e carta argentata, di quelle che tutti noi conosciamo. I due lavoratori, curiosi ma circospetti, naturalmente l’assaggiano. E muovono le bocche come fanno i cavalli masticando un buon fieno odoroso. Ma, a differenza di quelli equini, i loro sguardi si illuminano. “È buonissimo” sospirano, tra delizia e rassegnazione, i due giovani raccoglitori. E qui il documentario, documentario d’autore, si chiude lasciando allo spettatore la sensazione di aver capito, riguardo al mondo in cui vive, qualcosa di più profondo del solito. Questo è stato il 23° Festival del cinema africano, d’Asia e America latina, il cui centro è stata la Casa del Pane di Porta Venezia, conclusosi venerdì scorso: una inusuale grande finestra sul mondo in grado di cambiare le nostre prospettive, di liberarci da una visione ottusamente eurocentrica come ha saputo fare, su un altro piano, la cartografia di Arno Peters in cui a ogni paese è restituita la sua vera proporzione. Uno sguardo profondo su abissi e speranze, lontananze incommensurabili e vicinanze inquietanti. Come quella degli indios Tarahumara del Messico, abituati a parlare con gli spiriti degli antenati, e forse anche con Dio, lungo le immensità senza fine delle loro montagne e ora costretti a osservare pieni di muta indignazione un intraprendente imprenditore meticcio comprare la loro terra, senza che peraltro loro gliel’abbiano mai venduta, e farci sopra una grande funivia destinata a portare frotte di turisti nel cuore stesso della loro memoria.

“Noi non vogliamo emarginare i nativi, semmai vogliamo integrarli nello sviluppo e nel benessere.” proclama l’imprenditore a beneficio dei notiziari nazionali, con un disprezzo della verità a cui siamo forse più assuefatti noi dei poveri indios messicani. Ma intanto per far spazio ai nuovi resort e alle strutture commerciali saranno demolite le case, la scuola, la chiesa e perfino il cimitero, lasciando i vecchi a pensare se i loro morti resteranno ancora dove hanno vissuto, come fanno dai tempi della creazione. E anche a dove dovranno mai andare loro stessi. Da vivi e da morti.
Chissà chi sapeva che nella Siria devastata dalla guerra civile e dalla repressione genocida del regime di Assad è fiorita una creatività artistica senza precedenti. O che la Cina, lo stesso paese in cui è tradizione agghindare i cadaveri di certe donne per offrirle in spose nell'aldilà a ricchi signori morti per loro sfortuna in stato di celibato, molto più materialisticamente sta prendendosi a buon mercato l’oro e la terra della Tanzania. O cosa stia succedendo nella Tunisia che ha dato inizio alla primavera araba e come stiano cambiando le relazioni tra gli abitanti delle due sponde del Mediterraneo. E quali sono le cause della penetrazione del terrorismo in Mali? Perché una famiglia mista è accolta meglio in Senegal che qui da noi? Non è incoraggiante che un ragazzino dotato solo di un innato senso dell’umorismo riesca a mobilitare la sua comunità, nell’isola di Giava, Indonesia, affinché l’acqua rimanga bene comune e siano sconfitti i piani per privatizzarla? Possibile che una signora del Cairo andando al mercato ci spieghi i meccanismi del potere e della creazione del consenso meglio che qualunque nostro paludato commentatore? Siamo consapevoli del fallimento epocale del sistema di aiuti internazionali, la cosiddetta costosissima ‘poltiglia umanitaria’, il cui punto più basso è stato raggiunto ad Haiti nella gestione dell’emergenza dopo il terremoto del 2010 sotto la guida nientemeno di Bill Clinton? Qualcuno sta riflettendo sull’impropria connessione tra aiuti, cooperazione e logica del profitto e sulla debolezza manifestata dall’intero sistema delle cosiddette democrazie occidentali in quanto a capacità decisionali e visione del futuro? E così via. Per una settimana ognuno ha potuto percorrere in lungo e in largo il mondo seguendo i suoi interessi e le sue passioni. Dall’India alla Cina profonde, dall’Africa devastata ma piena di vita all’America Latina che ha archiviato per sempre il tempo delle dittature e cerca di riconoscere il suo futuro.

Ma abbiamo potuto guardare da questa finestra grazie all’aiuto di occhi partecipi, sentimenti profondi, sensibilità politiche e poetiche, artistiche e sociali come il cinema hollywoodiano e i suoi miti di cartapesta, certamente superiori per mezzi e fulgore di effetti speciali, quotidianamente e scientificamente ci abituano a non fare. Non mi è sembrato importante riportare chi ha vinto le varie sezioni, chi ha avuto più successo o applausi. L’importante, anche in vista del mitico Expo 2015 con cui il Festival ha costruito precise connessioni, è osservare che Milano, o almeno la sua parte più sensibile e aperta, affollando tutte le sale e le manifestazioni collaterali, ha dato l’idea di cogliere questa grande occasione di conoscenza e riflessione senza cui non è possibile neppure immaginare il nostro futuro. Con l’auspicio e la speranza che chi l’ha fatto non perda l’occasione il prossimo anno.
Tags:




